Andare in giro con Amelia è difficile. Non si possono fare due passi che si ferma ad accarezzare un cane, a guardare un cartello, a saltare dentro una pozzanghera. Adesso le è presa questa passione per le piume. Ogni volta che vede una piuma, la raccoglie e la stringe nella mano finché non arriva a casa, e poi chissà cosa ci fa. Anche adesso ne ha vista una e ci ha fatti fermare tutti. È una piuma grossa e grigia, di piccione. Si piega sulle ginocchia e la prende con due dita.
«Amelia, è sporchissima», dice Lorenzo. «Mettila giù.»
«Non è sporca», dice Amelia. La stringe nel pugno chiuso e vicino al petto. Con l’altro braccio teso in alto per stringere la mano del fratello, sembra la Statua della Libertà.
«Buttala via», dice Carlo tirandole il braccio. Amelia accelera, ma non lascia la presa. (Carlo ha le braccia muscolose, anche se non ha mai fatto un giorno di palestra. Lo invidio un sacco.)
«Quando possiamo venire da te?», chiedo. Carlo è l’unico di noi ad avere la console.
«Non lo so», dice Carlo. «Quando i miei non stanno lavorando. Se facciamo casino finisco nei guai.»
Annuisco. Cammino per un po’ trascinando i piedi, giocando a far sollevare la polvere. Ho sentito che c’è una tassa sulla polvere e mi diverte pensare che i miei pagano le tasse perché io trascino i piedi. Poi Lorenzo dice: «Andiamo a prenderci qualcosa da bere.»
«Vai avanti tu», dice Carlo. Amelia inchioda i piedi a terra.
«Perché ti sei fermata?», chiede.
«Mi stai stringendo troppo», dice Amelia.
«Se ti lascio te ne vai da qualche parte e non ti troviamo più», dice Carlo. «E poi ti mangiano i mostri.»
«Vuoi tenere la mano a me?», chiedo ad Amelia. La bambina dice di sì. Carlo la lascia, e lei corre verso di me. Le afferro la mano il più in fretta possibile, perché l’altro giorno mentre correva è caduta e si è sbucciata il ginocchio.
«Ho provato a convincere i miei a lasciarla a casa, ma dicono che non può stare da sola», dice Carlo.
«Ma che dici», rispondo. «A noi piace fare le passeggiate con Amelia. È la nostra bambina preferita.»
Amelia ride.
«Solo perché non è tua sorella», dice Carlo.
«Cosa vuoi da bere?», le chiedo. È così piccola che da quassù vedo soltanto i suoi capelli che rimbalzano. È bionda (ma anche suo fratello li aveva chiari da piccolo e adesso sono castani).
«Succo di frutta al mirtillo», risponde.
«E se non c’è al mirtillo?»
«Alla pera. E se non c’è neanche alla pera non voglio niente.»
«Neanche una Coca Cola?»
«La Coca Cola mi fa diventare grossa», dice battendosi il pugno sulla pancia. Non so se si rende conto di essere buffa.
«Perché raccogli le piume, Amelia?»
Lei scuote la testa. «È un segreto», dice.
«Ma io sono il tuo migliore amico.»
Amelia mi strattona. «Stiamo rimanendo indietro!», grida. Allungo il passo e lei mi trotta accanto.
Sono tre giorni che Amelia non viene più con noi. Carlo ha detto che passa tutto il giorno chiusa nella sua stanza, a parte per il pranzo e la cena.
«E anche in quel caso, tiene il broncio e non parla con nessuno. E quando finisce se ne torna indietro.»
«Che ridere», dice Lorenzo.
«Sì, ma io lo so che in realtà esce. Lo vedo che in cucina mancano le crostate. Solo che adesso vuole fare questa sceneggiata.»
«Cos’è successo?», chiedo.
«Mia madre ha buttato le sue piume. Ne aveva da vendere, sotto il letto. Quando Amelia l’ha scoperto si è messa a urlare, ma non c’era più modo di riaverle indietro.»
Annuisco. Voglio chiedere se hanno scoperto a che cosa le servivano, ma mi sembra di essere fastidioso con tutte queste domande.
«Ehi, vi ricordate quando voleva tutti i nostri incarti di caramelle?», dice Lorenzo.
Carlo ride. «Voleva farsi un vestito come quello delle bambole. È proprio una bambina strana.»
«Ha preso da te», dico. Carlo mi tira un pugno sul braccio.
Continuiamo a camminare per un po’. Camminare è la cosa che facciamo di più, quando usciamo insieme. (Non è che ci sia nient’altro da fare in questo paese.)
«Forse vuole diventare una biologa», dico. «È per questo che raccoglie tutte quelle piume.»
Carlo alza le spalle. «I bambini sono fatti così. È inutile cercare di capire.»
Voglio rispondere, ma non so cosa dire. Lorenzo sta masticando una gomma a bocca aperta, e fa schioccare la lingua in modo molto rumoroso. Per colpa di questo brutto vizio in seconda media l’avevano chiuso fuori dalla classe, ma ancora non gli passa.
«Però effettivamente ha una passione per gli uccelli», dice Carlo. Lorenzo scoppia a ridere e la gomma gli va di traverso. Lo guardo male, come per dirgli “ben ti sta”. Queste battute con le bambine non si fanno.
«In che senso?», chiedo a Carlo.
«Qualche settimana fa aveva preso a guardare questo film tutto il giorno. La gabbianella e il gatto, quello con il gabbiano che non sa volare e-»
«Sì, lo conosciamo.»
«Sì, beh, si era fissata. Ripeteva tutte le battute dei personaggi a memoria, e infatti mia madre si è spaventata e l’ha nascosto. Magari è per questo.»
«Può essere», dico. Poi mi viene in mente una cosa. Non so se sia il caso, ma alla fine la dico. «Senti, ma non è che vuole imparare a volare?»
«Ma ti pare scema?», dice Carlo.
«Però la gabbianella alla fine impara a volare. Cioè, è possibile che voglia fare un esperimento. Io quand’ero piccolo ho visto I fantastici quattro e ho provato a darmi fuoco.»
Lorenzo ride. Mi sento le guance bruciare. (Meno di quando mi sono dato fuoco.)
«Adesso il tuo nome sarà Torcia umana per sempre», dice. Anche Carlo ride, ma sembra preoccupato. Forse ha capito cosa voglio dire.
«Torno a casa», dice. Gli dico che vengo anch’io. Lorenzo ci dà una pacca sulla spalla e ci dice di stare tranquilli. Io non so se riesco, però.
Amelia mi ha concesso di entrare nella sua stanza. Devo ammettere che mi sento orgoglioso. Ho bussato alla sua porta e la sua vocina acuta ha gridato: «Non voglio uscire!»
«Non devi uscire», ho detto. «Sono Matteo, il tuo migliore amico. Posso entrare?»
Ho sentito le molle del letto cigolare ed è venuta ad aprire la porta. Aveva le sopracciglia aggrottate e il labbro sporgente. Era buffa, ma non l’ho detto.
La sua stanza è dipinta di giallo, con dei fiori disegnati a matita su tutte le pareti. Ci sono giocattoli su tutti gli scaffali, e una mensola con una quindicina di libri in ordine d’altezza. La finestra accanto al letto ha le tende bianche. L’intera stanza sembra tale e quale a quella che si potrebbe vedere su una rivista commerciale. Sulla scrivania ci sono dei fogli sparsi, sembrano dei disegni.
Amelia si chiude la porta alle spalle e si butta sul letto. Si copre la faccia con il cuscino. Io mi siedo a terra, con le gambe incrociate.
«È tanto tempo che non ti vediamo», le dico. «Ci sei mancata molto.»
Amelia scuote la testa con forza.
«Sei offesa con me? Ma non ho fatto niente.»
«No!», dice, abbassando il cuscino.
«No cosa?»
«Non sono offesa con te», dice. Ha ancora il broncio, ma ha gli occhi più tranquilli. Stendo le gambe di fronte a me. Da qui riesco a vedere gli incarti delle crostate buttati sotto il letto.
«Con chi sei offesa, allora?»
Amelia mi fa segno di avvicinarmi. Mi alzo e mi siedo accanto a lei, sul letto.
Si copre la bocca con le mani e sussurra: «Mamma ha buttato via tutte le mie piume.»
«Davvero?», dico. «Ma non l’ha fatta apposta, giusto?»
«Sì invece!», dice. Spalanca gli occhi e spinge di nuovo la faccia contro il cuscino. «Sì invece», ripete con la voce soffocata.
«Ma a cosa ti servono, tutte queste piume?»
Amelia rimane in silenzio.
«Se mi dici a cosa ti servono, ti aiuto a trovarne altre», dico. La bambina abbassa il cuscino e mi guarda.
«Mi servono a costruire le ali», dice.
Sento che il cuore mi si fa pesante. «Ma le persone non volano, Amelia», le dico.
Lei annuisce guardando fuori dalla finestra. Vorrei continuare il discorso, ma non mi sembra che mi stia ascoltando.
«Mi devi aiutare», dice. «Altrimenti sarà troppo tardi.»
«Ti aiuto», dico. «Ma mi devi promettere che non proverai a buttarti da qualche parte. Va bene?»
Amelia sorride. Mi tende il pugno chiuso con il mignolo alzato. Incrociamo i mignoli, come quando ero bambino.
«Ora siamo soci», dice. Chissà dove l’ha imparata questa parola.
Abbiamo raccolto una cinquantina di piume in tutto. Non ha voluto chiedere agli altri perché non si fida (sempre più orgoglioso), anche se loro se ne sono accorti già da un pezzo. Mi hanno fatto un sacco di domande, ma io non so cosa rispondere. Amelia i segreti li sa tenere.
Oggi le porto lo zaino a casa. Le piume le tengo in camera mia, perché da quando i miei hanno trovato i porno sulla scrivania non ci mettono più piede. Ma oggi le devo portare da lei.
«C’è il tuo fidanzatino!», dice ridendo la madre di Amelia. Una voce acuta dal piano di sopra grida che “non è il mio fidanzato, è un amico”.
«Migliore amico», preciso.
«Grazie per averla fatta uscire», mi dice la madre a bassa voce. «Per fortuna ha smesso di raccogliere quelle cose, che chissà quante malattie portano.»
«Di niente», rispondo. Poi salgo le scale.
Amelia mi aspetta in camera sua, seduta a terra con le gambe incrociate. Le dico di alzarsi da lì, che è freddo e sporco, ma lei alza le spalle.
Appena le passo lo zaino, apre la cerniera e lo capovolge. La aiuto a scuoterlo finché tutte le piume non sono per terra davanti a lei. È una strana ammucchiata: ci sono piume grigie e grosse di piccione e altre soffici e bianche di un uccello che non conosco. Ce ne sono anche nere, di corvo o di merlo, e altre di forme strane. Abbiamo raccolto anche quelle spezzate e un po’ rovinate, e alcune sono sporche di terra e di fango. Mi viene un certo schifo a pensare che tutte quelle cose sono state dentro il mio zaino per settimane.
Amelia ci ficca le mani dentro. Gliele tiro via, afferrandola per il polso.
«Ti vengono le malattie», le dico.
«Questa cosa te l’ha detta la mamma», dice. Tira strattoni, ma io la tengo forte.
«Sì, ma è comunque vera», rispondo.
«Non è vero, hai paura che se mi ammalo se la prende con te.»
Sbuffo e le lascio il polso. Lei immerge le mani nel mucchio e comincia a contare.
Non ho niente da fare se non guardarla. Non mi sembra che cresca mai, questa bambina. Ha sempre gli stessi occhi, sempre la stessa faccia, sempre lo stesso modo di muovere le mani. Persino i suoi capelli mi sembrano sempre della stessa lunghezza. Solo i vestiti sono cambiati. Un anno fa metteva gonne di tulle rosa, adesso porta già i pantaloni. Per una come lei, la gonna non poteva durare più di tanto.
Ha finito di contare. Sta a braccia incrociate, con lo sguardo arrabbiato. «Non sono abbastanza», dice.
«Ma sono tantissime», rispondo.
«Non sono abbastanza», ripete. Ha gli occhi lucidi e la faccia rossa. Le metto una mano sulla testa.
«Vuoi che ne raccogliamo altre?»
«Non si può», dice. «Ormai tutti gli uccelli sono volati via.»
Mi ero dimenticato che è già autunno.
«Non tutti gli uccelli volano», dico.
Amelia mi guarda. In realtà ho solo detto una cosa a caso per renderla felice.
«Per esempio, le galline non volano», dico.
«Ma non esistono galline selvatiche.»
«Mia nonna ha delle galline», dico.
«Ha una fattoria?»
«No, un pollaio in giardino. Ma è grande, e ci sono tante galline. A nessuno può dispiacere se ci prendiamo un paio di piume.»
Amelia batte le mani due volte. «Allora è deciso», dice. Sono riuscito a non farla piangere anche oggi.
«Quindi questa è la tua sorellina?», chiede la nonna.
«No», rispondo.
«Bene, bene», dice sedendosi sul divano con un tonfo. Amelia tiene le mani ficcate nelle tasche e si guarda in giro.
«Andiamo a raccogliere le uova, nonna», dico tendendo la mano alla bambina. Nell’altra mano ho una busta per la spesa vuota. Lei continua a tenerle in tasca, così la devo prendere per il braccio.
«Bravi ragazzi», dice la nonna con un sorriso giallo. «Le ciotole sono in cucina.»
Amelia mi fa cenno con la testa di andare.
«Puzza», dice quando siamo nel giardino.
«È l’odore delle persone anziane», le rispondo. Lei storce il naso. «Un giorno sarai vecchia anche tu», le dico con tono di rimprovero, ma lei non mi ascolta neanche.
«Perché dice che sono la tua sorellina?», chiede.
«Si confonde», dico. «Non ho mai avuto sorelle, né grandi né piccole.»
Il pollaio si trova in fondo al giardino. È un recinto vecchio, coperto di ruggine tanto che sembra dipinto di rosso. A un lato del recinto c’è attaccata una mangiatoia, piena a metà di acqua e insetti annegati. Nell’angolo, cinque cassette di legno rovesciate fanno da riparo per la notte. Il pavimento è così pieno di segatura che il marrone della terra non si vede.
Scavalco il recinto e sollevo Amelia per le ascelle. Le galline (che in realtà non sono tante) sono entusiaste del nostro arrivo. Vorrei essermi portato dei tappi per le orecchie.
«Comincia a raccogliere le piume per terra», dico a voce alta per superare gli starnazzi. Amelia fa cenno di sì con la testa e ispeziona il pavimento, mettendosi quasi a gattoni. Io alzo le cassette di legno e raccolgo le uova. Ogni tanto Amelia corre a mettere una piuma nella busta.
«Quante ne hai trovate?», chiedo con la ciotola di uova tra le mani.
«Non tante», dice. «Dieci e un altro poco. Hai un’altra nonna?»
«No», dico. «Però le piume non sono finite.»
Metto giù le uova e dico ad Amelia di stare zitta. Le galline si sono abituate alla nostra presenza, e ora zampettano tranquille per il perimetro del recinto. Mi avvicino con calma a una di loro e la seguo finché non si ferma. Abbasso le braccia e la sollevo da terra, tenendole le ali attaccate al corpo. La gallina si guarda intorno, ma non reagisce.
Amelia si avvicina in punta di piedi. «Staccale una piuma», dico.
«Non si fa male?», chiede.
«È come se a te strappano un capello», rispondo.
Amelia fa un respiro profondo e tira una piuma dalla coda. La gallina non apprezza. Cerca di liberare le ali e muove le zampe in aria, come per nuotare. Ho paura che possa graffiare Amelia e la lascio cadere. Le altre galline sentono e urlano, correndo da una parte all’altra del recinto.
Amelia è molto più coraggiosa di me. Sta in mezzo a questo finimondo senza spostarsi di un millimetro, e batte le mani e strizza gli occhi e ride, con la piuma stretta tra le dita.
«La prossima la prendo io», dice.
«Va bene», rispondo. «Ma aspettiamo almeno un po’.»
Le galline non sono animali intelligenti; dopo dieci minuti si sono già dimenticate di quello che è successo. Sono tornate a zampettare e a beccare i semi nascosti nella segatura.
Amelia si guarda intorno con attenzione. Sceglie una gallina e me la indica in silenzio. Poi si avvicina in punta di piedi e la segue per quasi mezzo recinto. Molto lentamente, si abbassa e la abbraccia. La gallina fa dei movimenti bruschi, ma si adatta presto alla situazione. Sembra molto più grande, tra le braccia della bambina.
«Muoviti!», mi dice. Prendo una piuma, una grossa dal fianco, e comincio a tirare.
«Sei pronta?», chiedo.
«Sì!»
«Tienila forte, non farla scappare.»
Giro il polso e allontano il braccio. La gallina muove le ali e le zampe e urla. Anche Amelia urla, stringendola ancora più forte al petto come una mamma che non vuole far cadere il suo bambino. Le altre galline corrono verso la loro compagna, verso Amelia.
«Lasciala andare», grido. Amelia forse non mi sente, in mezzo a tutto quel rumore.
Le prendo le braccia e le apro. La gallina cade a terra, le compagne la ignorano e continuano a venire nella nostra direzione. Sollevo Amelia e la lancio dall’altra parte del recinto, poi scavalco anch’io.
È caduta con le ginocchia e con le mani. Io non mi sono fatto niente. Sia le uova che le piume sono rimaste dall’altra parte, ma la busta si è rovesciata. Penso che se perdiamo anche queste Amelia sarà molto triste, così mi faccio coraggio e scavalco di nuovo. Le galline mi corrono incontro, ma non mi fanno nulla. Raccolgo tutto e porto dall’altra parte busta e ciotola.
Amelia è seduta a terra, che si guarda le mani.
«Ti sei fatta male?», chiedo.
Lei annuisce.
«Vieni con me, che ti disinfettiamo.»
Appoggio tutto davanti alla porta e accompagno Amelia nel bagno. Ha i capelli arruffati e i pantaloni sporchi, e le mani arrossate e piene di terra. Le prendo e le sciacquo nel lavandino. L’acqua si dipinge di un rosso chiaro.
«Va meglio?», chiedo.
Lei annuisce di nuovo.
Adesso che le mani sono pulite, si vedono i piccoli graffi sulla pelle. È roba da nulla, al massimo brucia un po’. C’è un graffio profondo vicino al polso, è da lì che esce il sangue. Le dico di stare ferma e cerco del disinfettante e dei cerotti.
«Te l’hanno fatto le galline, quel graffio?», le chiedo.
«No, sei stato tu», risponde.
«Impossibile», dico. Ho trovato l’acqua ossigenata, i cerotti ancora niente. «Io non potrei mai farti male.»
«Ma è vero. Sei stato tu con il recinto.»
La guardo. «Ti sei graffiata con il recinto?»
«Sì», dice.
«E ti senti bene?»
«Sì, però mi brucia.»
«Va bene», dico. «Adesso ti disinfettiamo, poi ti mettiamo un cerotto e poi… poi vediamo.»
Le verso l’acqua ossigenata sul graffio. Lei fa una smorfia. Esce un grosso batuffolo di schiuma bianca, che lavo via con l’acqua. Continuo a guardarla, ma mi sembra che stia bene.
«Non ci sono cerotti», dico. «Quindi mettiamo questa fascia, che è anche più bella.»
Le lego un pezzo di garza attorno al polso.
«Perché sei agitato?», dice.
«Non sono agitato», rispondo.
«Invece sì. Ti tremano le mani. Non dirmi le bugie.»
Sospiro. «Tu sei sicura di stare bene?»
Lei annuisce.
Mi alzo in piedi. Si alza anche lei, sfregandosi il polso.
«Forse dobbiamo andare al pronto soccorso», dico.
Lei scuote la testa con forza. «Andiamo dalla mamma», dice.
«Ma se la tua mamma scopre che ti sei fatta male per colpa mia, poi non possiamo più stare insieme», dico.
«Tanto ormai le piume le abbiamo prese.»
La guardo male. «Non avevi detto che non erano abbastanza?»
«Facciamo che bastano.»
«In ogni caso non possiamo dirlo alla tua mamma.»
«Sì, sì», dice. «La porto io la busta.»
Sua madre non è molto contenta, quando ci vede arrivare.
«Cosa le è successo?», chiede.
«È caduta mentre correva in strada», dico.
«E il polso?»
«Si è graffiata su una pietra.»
La busta la tengo io, da quando siamo entrati. La madre di Amelia si china e le prende la faccia tra le mani.
«Beh, tanto abbiamo fatto tutti i vaccini», dice. Sento le mie spalle che finalmente si rilassano. (Sarei potuto svenire da un momento all’altro.)
«Però vai comunque a farti un bagno.» Amelia incrocia le braccia e non si muove. La madre si gira verso di me.
«Forse è meglio che per un paio di giorni non esca», dice. «Non mi piace che vada in giro a rotolarsi per terra.»
Dico di sì. Un paio di giorni si possono sopportare, alla fine. Dopo aver ripetuto ad Amelia di farsi “questo benedetto bagno”, la madre si allontana. Do la busta ad Amelia e lei corre al piano di sopra. Mi saluta dalle scale, e muovendo le labbra senza parlare mi dice: Ci vediamo presto.
Invece è sparita di nuovo. Per sette giorni non ci ha più seguiti nelle nostre uscite. Carlo dice che è colpa di sua madre, che vuole che esca con bambini della sua età. Non l’ha proprio detto, ma l’ha fatto capire. Pensava di iscriverla a un doposcuola, di quelli con gli animatori eccetera.
«E lei cosa ne pensa?», chiedo.
«Boh», dice Carlo. «Non mi sembra sconvolta.»
«Va bene», dico.
«Comunque lo sappiamo che ti manca, ma è bello stare noi tre da soli», dice Lorenzo.
È vero che la bambina ci risucchiava troppo tempo. E che adesso che siamo di nuovo un gruppo di maschi, ci divertiamo molto di più. Però essere abbandonati è un brutto colpo.
«Tanto per dire, stasera potremmo andare in spiaggia», dice Lorenzo.
«Che ci vai a fare in spiaggia con questo freddo», dico.
«Ci chiudiamo in qualche locale. In spiaggia di ragazze ce n’è sempre, a tutte le stagioni», dice alzando le spalle. Carlo ride e la discussione si chiude lì.
Ma poco prima di cena comincia a piovere a dirotto. Nessuno di noi tre ha l’ombrello. Ci ripariamo sotto il balcone di una casa, mentre ci riscaldiamo le mani con il fiato.
«Qualcuno chiami i suoi prima che ci congeli il fegato», dice Carlo.
«Non ho soldi sul telefono», dico.
Carlo sospira e tira fuori il suo. In realtà di soldi ne ho, ma se vengono a prenderci i genitori di Carlo, magari viene anche Amelia. Lorenzo deve averlo capito, ed è per questo che sta zitto.
Il padre di Carlo viene a prenderci dopo venti minuti. Deve scendere e aprirci la porta, perché abbiamo tutti le dita così congelate che non riusciamo quasi a muoverle.
«Vi accompagno tutti a casa?», chiede.
«In realtà volevamo andare in spiaggia», dice Lorenzo.
«Non vi porto in spiaggia con questo tempo», dice il padre. Lorenzo si gira verso di noi e fa una smorfia, tenendosi una mano davanti alla faccia in direzione del guidatore. In ogni caso, sono abbastanza sicuro che il padre l’abbia visto.
«Ma se proprio non volete tornare a casa, posso chiedere a mia moglie di fare due piatti in più», dice. Rispondiamo di sì, poi stiamo tutti zitti per il resto del viaggio.
Giochiamo finalmente alla console di Carlo. Ci sono così tanti giochi che potrei passare un pomeriggio solo a guardare i titoli. Lorenzo fa finta di niente, ma lo so che anche lui è impressionato.
«Quando sarò padre, la prima cosa che comprerò per mio figlio sarà una console», dico.
«Allora comincia a interessarti alle ragazze e lascia perdere le bambine», dice Lorenzo.
Arrossisco e mi giro, per controllare che nessuno abbia sentito. Amelia non è ancora venuta a salutare.
La signora ci grida di andare a chiamarla, che è quasi pronto.
«Matteo, vai tu», dice Carlo. Io annuisco e salgo le scale del primo piano. La sua porta è chiusa, e c’è qualcosa davanti che impedisce di aprirla. Forse una sedia, o una scatola.
«Amelia?», chiamo.
«Chi è?», risponde lei.
«Matteo», dico. «Il tuo migliore amico», aggiungo dopo un po’.
«Vuoi entrare?», dice.
«Devi scendere, è pronto da mangiare.»
«Non ancora», dice.
«Va bene, ma non fare troppo tardi», dico. «Altrimenti ci mangiamo tutto noi.»
Amelia fa una piccola risata. Io scendo le scale e avviso la madre che scenderà a momenti. Lei mi guarda per un paio di secondi e annuisce.
Da mangiare c’è pasta al pesto e una fetta di carne.
«Da me si mangia solo primo o secondo», dico.
«Noi ci teniamo che i nostri ragazzi crescano», dice il padre. Parla poco, ma ha una voce che sembra sempre una risata e una risata che sembra un’esplosione. (Forse Carlo ha tutti quei muscoli perché mangia tanto.)
Sento dei rumori, e poi una porta che si apre. «Finalmente», sospira la madre. Sentiamo dei piccoli passi sopra le nostre teste, ma nessuno scende dalle scale.
«Amelia?», dice la madre. I passi si fermano. Un’altra porta si apre e si chiude.
«Dove sta andando?», chiede al padre. L’uomo alza le spalle.
Saliamo le scale. Non c’è da nessuna parte. C’è una porta che va in soffitta. Salgono solo Carlo e sua madre, perché la soffitta è piccola e a starci in tanti si soffoca.
Sento che la chiamano, ma Amelia non risponde.
«Si fredderà la pasta», dice il padre.
Si apre un’altra porta, con un rumore metallico e pesante. La madre grida qualcosa, Carlo scende le scale di corsa. Mi guarda e dice: «Sali.»
Amelia è sul tetto. La sua famiglia ha il tetto di mattoni, invece di quello spiovente, perché tanto non piove abbastanza spesso. È circondato da un muretto alto più o meno quanto lei, e adesso l’acqua ha fatto un piccolo lago a terra. Piove da affondare una nave, ma lei non sembra avere freddo. Ha un impermeabile blu che la copre tutta tranne le scarpe. Sta un po’ distante dalla porta e ascolta la madre, che le grida da dentro la soffitta di rientrare in casa. Io ho preso un ombrello dall’ingresso.
«Amelia», grido.
«Non c’è bisogno di gridare», dice lei. «Ci sento bene.»
Esco sul tetto, tenendo l’ombrello con tutte e due le mani. «Amelia, perché non vuoi rientrare?», dico.
«Ho da fare una cosa prima», dice. Si avvicina al muretto, e io la seguo. Le scarpe si stanno riempiendo d’acqua.
«Me l’avevi promesso, Amelia», dico. «Mi avevi promesso che non si saresti buttata dal balcone.»
Segue il perimetro del muretto, a passi piccoli e occhi bassi. Vorrei avvicinarmi ancora, ma ho paura di metterle fretta. Ho paura di tante cose, adesso.
«Me l’hai promesso con il mignolo», dico.
«Stai zitto», dice. La guardo che continua a girare. Carlo e Lorenzo sono accanto a me, senza ombrello.
«Che sta facendo?», dice Carlo.
«Prendetela», grida sua madre da dietro la porta.
Lorenzo corre verso Amelia. Ha i capelli schiacciati sulla faccia, e le gocce d’acqua gli cadono dalle orecchie a sventola come orecchini. La prende per le spalle e la solleva, ma Amelia si mette a urlare. Si muove come un serpente, tirando calci e appoggiandosi al muretto con i piedi.
«Lasciala», grido. Lorenzo la trascina fino al centro del tetto, ma Amelia si libera e cade per terra. Corre di nuovo verso il muretto, ma stavolta nessuno la insegue.
«Che facciamo?», chiede Carlo.
«Amelia, torna qui», dico.
I genitori di Carlo litigano. Lui sospira e si mette le mani in tasca.
Amelia si ferma e si accovaccia. C’è una parte buia nel muro, un difetto di costruzione. Si toglie l’impermeabile. Ha una maglia coperta di piume.
«Amelia», grido.
Amelia mette le mani nella parte buia. Si siede per terra, sull’impermeabile, e stringe le gambe e le braccia al petto.
Mi avvicino piano. Lei non mi vede, perché ha la testa in mezzo alle braccia, ma forse mi sente. Mi accovaccio e la copro con l’ombrello, anche se è già bagnata.
«Stai piangendo?», chiedo.
Amelia alza la testa. Ha la faccia bagnata di pioggia e sta sorridendo. In mezzo alle braccia ha un bagnatissimo piccione.
«Questo piccione abita qui e ogni volta che piove non sa dove andare», dice. «La sua casa ha i buchi e si bagna tutto.»
«Ma perché le piume?», chiedo.
«Se vede che sono umana si spaventa», sussurra. Le piume sono incastrate tra i nodi della maglia. Alcune stanno già cadendo, ma la maggior parte reggono bene.
«Alla fine sono avanzate», dice. «Puoi averle tu se vuoi.»
«Non vuoi proprio rientrare?»
«Non posso, il piccione ha freddo.»
L’uccello mi guarda. Con le piume tutte attaccate al cranio, i suoi occhi sembrano enormi.
«Allora rimaniamo qui», dico. «Come due migliori amici.»
Mi siedo accanto a lei, anche se mi bagno tutti i pantaloni. Tanto, l’ombrello ci copre tutti e tre. Dobbiamo solo aspettare che smetta di piovere.
Antonella Massaro, 2017
Ehi! Se ti è piaciuto questo racconto, potrebbe piacerti anche Brina. Dagli un’occhiata, la prossima volta.
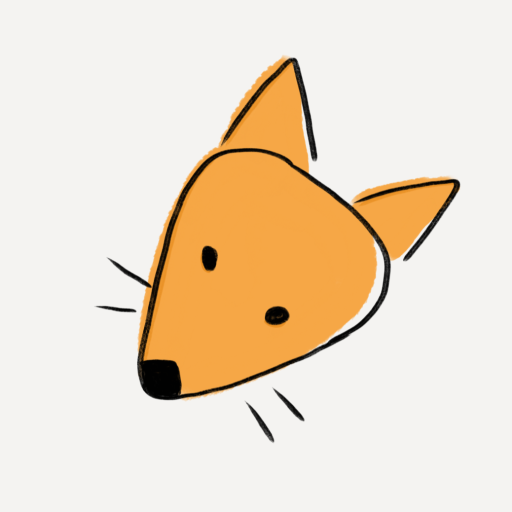
Lascia un commento