Da piccola, quando mio nonno mi parlava era tendenzialmente per due motivi: mettermi in competizione con i miei cugini, oppure parlarmi di sé. Non era mai sembrato interessato a quello che avevo da dirgli, il che col senno di poi era anche comprensibile: alla sua età, i crucci di una tredicenne dovevano sembrargli questioni da poco. Ma per un’adolescente non essere ascoltata equivale a non esistere; perciò, non ero mai riuscita a perdonarlo per non aver fatto almeno finta di trovarmi interessante. Del resto, anch’io lo ascoltavo con mezzo orecchio, perché i suoi racconti di quand’era giovane mi sembravano troppo distanti da me – pensavo di vivere in un mondo diverso, e che quindi non potesse riguardarmi più di un fantasy.
Di conseguenza, anche quando mi parlava di Ivrea la visualizzavo come un posto più lontano nel tempo che nello spazio. Mi aveva detto che era poco più grande di un paese e che era al Nord, ma io al Nord non c’ero mai stata, quindi era un’informazione che non voleva dire nulla; così come non volevano dire nulla le spiegazioni su che tipo di lavoro svolgesse, perché il nonno lavorava con delle macchine che non si usavano più.
Notavo invece sempre il tono con cui mi parlava di Ivrea: agrodolce, lo sguardo sfuggente, cose difficili da associare a un uomo dalle opinioni così definitive. Una volta chiesi a mia madre cos’era successo a Ivrea, pensando che se il nonno avesse voluto dirmelo l’avrebbe già fatto. Lei all’inizio non capì, ma le spiegai gli sguardi e ci rifletté. «Papà era una persona molto intelligente, ma poco istruita», mi disse a voce bassa, con il tono di qualcosa che non va ripetuto. «Non ha mai finito le elementari. In quell’ambiente si sentiva un po’ fuori luogo, credo.»
Lì per lì mi venne da ridere a pensare al nonno che non aveva neanche finito le elementari e poi veniva a rinfacciarmi che i miei voti erano più bassi di quelli di mia cugina. Pensai che potessi permettermi di non ascoltarlo, ogni tanto. Opinione che si consolidò quando, a quindici anni, mi disse che dovevo smetterla di vestirmi da maschiaccio, che ero ridicola. E che per l’amor di Dio, mangiassi un po’ di più, che con quelle tettine minuscole sembravo ancora una bambina. Io gli gridai che mi sarei vestita come mi pareva e che se voleva vedere delle tette grosse se le facesse crescere lui. Le nostre conversazioni si interruppero lì.
A ventinove anni vinsi un concorso a Ivrea. Era il periodo in cui avevo capito che se volevo insegnare il prima possibile dovevo abbandonare l’idea di restare in Sardegna, quindi a settembre
feci le valigie, gli accordi per una casa in affitto già presi. Mi ricordavo che ci avesse vissuto il nonno, ma volevo che la città appartenesse a me, avesse i miei ricordi e i miei legami. La domanda che più mi ponevo, sul treno piccolo ed elegante che mi portava da Torino a Ivrea, era: da dove iniziare. Mi ci era voluto molto tempo per finire di esplorare la città in cui ero cresciuta, un po’ per pigrizia e un po’ per vastità. Ma quando arrivai a Ivrea, dopo essermi districata tra snowboard e sci degli altri passeggeri, mi trovai di fronte una mappa della città in cui mi sembrava tutto davvero vicino. Mi ricordai del “poco più grande di un paese”, e quella fu la prima volta che mi tornò in mente il nonno. Feci comunque una foto alla mappa, tanto per essere sicura di ritrovarla, con l’imbarazzo di chi non vuole essere percepita come turista.
Andai a prendere le chiavi della mia nuova casa, in una zona residenziale a pochi passi dalla stazione. Dalla finestra al secondo piano si vedevano i picchi delle Alpi, e la cosa mi emozionò in modo inaspettato. Decisi che avrei imparato i loro nomi, anche se non sapevo neanche quello del fiume che avevo appena attraversato. L’idea era di sistemare subito quelle poche cose che mi ero portata, ma a vincere furono tre priorità: l’ansia di vivere in un posto nuovo, la curiosità di vivere in un posto nuovo, e la fame. Mi assicurai che il cellulare fosse carico e uscii.
Arrivata in centro, mi infilai in una piccola trattoria economica. Mi aspettavo di essere quasi sola, invece non c’erano più di tre tavoli liberi. Prima di sedermi, la mia attenzione fu attirata dalle pareti, tappezzate da due elementi principali. Dove non c’erano stendardi con picche o scorpioni, c’erano foto d’epoca in ambiente industriale, con ragazzi che sorridevano alla fotocamera o concentrati sul lavoro. Istintivamente, mi misi a cercare mio nonno. Le analizzai con attenzione, ma riconobbi solo alcuni degli oggetti, una scrivania uguale a quella che avevo da piccola o una grossa calcolatrice che avevo visto prendere polvere in cantina. Quando tornai a concentrarmi sul locale, tutti i posti erano stati occupati. Fui contenta, perché questo mi dava la possibilità di soddisfare quella curiosità improvvisa.
Cercai un altro locale, entrai, stavolta mi sedetti prima di guardarmi intorno. Gli stendardi c’erano sempre; niente foto, ma un poster vintage di Olivetti a svolgere il loro ruolo.
Divenne un gioco tra me e la città. Ogni mattina prendevo il caffè in un posto diverso, due volte alla settimana andavo a mangiare fuori, e in ogni luogo andavo a caccia di mio nonno. Alcune foto – le più fotogeniche – sbucavano ovunque, ma una nuova c’era sempre. Mi dicevo: Prima o poi spunterà fuori. Quanta gente avrà lavorato su queste macchine da scrivere?
Questa vaga idea che avevo di mio nonno da giovane rimase rilegata alle foto, che con il loro bianco e nero mantenevano una distanza da me che ritenevo giusta e necessaria, finché un giorno non finii di fronte a un grosso edificio industriale. Mi parve brutto; mi parve abbandonato, e fuori luogo così vicino al centro storico. Ma c’era qualcosa nella sua forma che andava oltre la bruttezza, una sorta di intenzione. Cercai di cosa si trattasse, e scoprii che era progettato per somigliare a una macchina da scrivere. Che fissazione, pensai. Di nuovo, non riuscii a evitare di pensare al nonno, ma questa volta il luogo a cui lo collegavo non era in bianco e nero. Da allora, la sua presenza si espanse a tutta Ivrea. Mio nonno appariva come un fantasma nelle infinite possibilità di gioventù che gli attribuivo, seduto al bar circondato da amici, da solo su una panchina al parco, a lamentarsi di un film uscendo dalla Serra. Pensavo: forse al nonno piaceva questo locale. Oppure: forse il nonno preferiva passare accanto al fiume, quando c’era bel tempo. Ogni tanto aggiungevo, timidamente: come me. Ma nelle foto continuavo a trovare uomini che non gli somigliavano affatto, e in un certo senso mi chiedevo se fosse davvero possibile che lui, austero, presuntuoso, arrogante, si trovasse in mezzo a quei ragazzi sporchi di inchiostro.
Una mattina decisi che sarei andata all’Archivio Olivetti, per risolvere la questione della foto una volta per tutte. Ne parlai con le mie colleghe, che rimasero tutte incuriosite da questo mio legame generazionale con Ivrea.
«È bella questa cosa», aggiunse una di loro con un tono affettuoso, «questa tua determinazione a ricordare tuo nonno. Da quanto tempo non c’è più?»
«Ah, lui…»
Balbettai che era morto da un paio d’anni, un tentennamento che venne attribuito a un dolore ancora vivo e non alla bugia inventata sul momento per coprire l’assurdità della situazione che mi era appena apparsa lampante. Le testimonianze delle mie colleghe, che per avvicinarsi a me condividevano esperienze di un dolore che io non avevo vissuto, mi fecero sentire ancora più in colpa. Non passai dall’Archivio Olivetti, tornai dritta a casa e cercai voli per la Sardegna.
Finii per tornare quasi tre mesi dopo, per le vacanze di Natale. Non dissi ai miei che andavo a trovare il nonno, non avrei saputo spiegare il motivo. Non aveva mai cambiato casa, ma feci fatica a ricordarmi la strada.
Mi aprì quella che immaginai essere la badante. Mi guardò con diffidenza quando dissi che ero la nipote, ma forse qualche somiglianza c’era, o forse non le importava. Mi indicò dov’era: in salotto, a guardare la televisione. Era in sedia a rotelle, con una coperta grigia sulle gambe. Il conduttore in tv strillava su qualche inchiesta a proposito di un omicidio. Abbassai un po’ il volume, poi gli toccai la spalla. «Nonno.»
Non si girò. Lo ripetei, senza risultato. Lo chiamai per nome: «Gustavo.»
Si voltò. Mi riconobbe subito, credo; io non fui altrettanto veloce. Capii che non avrei ricevuto le risposte che speravo, ma tentai comunque. «Nonno», chiesi, «ti ricordi di Ivrea?»
Mi guardò per qualche secondo, poi scosse la testa, piano. Annuii. Quando riportò lo sguardo alla televisione, alzai al volume e mi misi a cercare le foto.
Appese non ce n’erano mai state. C’era un album però, abbandonato sul tavolino da tè, e lì una foto di quella che immagino fosse un’officina di Ivrea. Un gruppo, sette giovani uomini in divisa accovacciati sui talloni. Mio nonno era il terzo. Cercai di guardarlo negli occhi, per trovare una traccia dell’arroganza che era sempre stata, per me, la sua caratteristica definente, ma era una presunzione moderna: a malapena si distingueva il viso. Capii che se avessi trovato quella foto da
qualsiasi altra parte non l’avrei riconosciuto.
Mi sedetti qualche minuto a guardare la televisione con lui, ma ero intollerante a certi programmi. Lo salutai, chiamandolo per nome. Lui allungò una mano verso di me e disse: «Stai bene.»
Mi misi in guardia. Mi sta dicendo che sto bene fisicamente, pensai, che non mi vesto più da maschio, che sono ingrassata. Ma lo guardai in faccia e di nuovo mi stupii di quello che avevo davanti. No, il nonno non ricorda più nulla di tutto ciò, perché ora è una persona diversa. Sono venuta qui cercando un ragazzo che non esiste più, e non trovo neanche la persona verso cui provavo tutto quel rancore. Per loro due è tardi ormai, ma con questa persona nuova abbiamo appena iniziato.
Gli presi la mano, sentendo le ossa sporgenti sotto la pelle. «Sì», risposi, «sto bene.»
Antonella Massaro, 2024
Ehi! Se ti è piaciuto questo racconto, potrebbe piacerti anche Un gatto e una fetta di prosciutto. Dagli un’occhiata, la prossima volta.
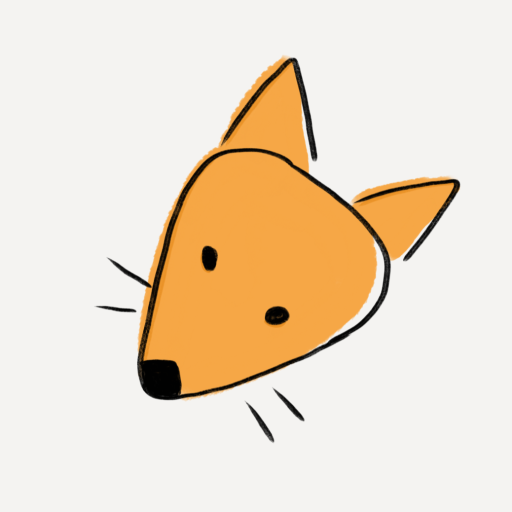
Lascia un commento